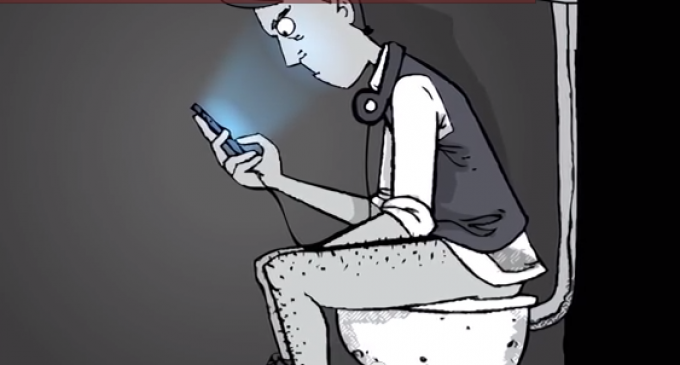Nel giorno di Pasqua, è morto Rubin Carter ( 1937-2014). Pugile nero dal
gancio sinistro formidabile, sfidante al titolo mondiale dei pesi medi, non
ricordato principalmente per la sua carriera sportiva, ma per essere stato una
delle vittime della cattiva giustizia americana di stampo razzista più
ispiratrici del ventesimo secolo.
“Lafayette Bar and Grill”, Patterson, New Jersey, 1966, alle
2.30 del mattino. Queste le coordinate geografiche e temporali in cui la storia
di Rubin “Hurricane” Carter ha inizio. Una storia che per me ha una sola voce
narrante, quella nasale di Bob Dylan, che la ripercorre tutta in quel pezzo da
pelle d’oca che è, appunto, “Hurricane”, il brano d’apertura di Desire del ’76.
«Pistol shots ring out in the
barroom night
Enter Patty Valentine from the upper hall.
She sees the bartender in a pool of blood,
Cries out, "My God, they killed them all!"»
Enter Patty Valentine from the upper hall.
She sees the bartender in a pool of blood,
Cries out, "My God, they killed them all!"»
Inizia così gli oltre otto minuti
di una delle ballate più affascinanti della storia della musica e il racconto
di una vicenda che sarà per molti simbolo di ingiustizia e discriminazione
razziale.
Due uomini di colore entrano in un
bar di Paterson e aprono il fuoco. Fred Nayouks e il barista Jim Oliver vennero
uccisi sul colpo. Una donna, Hazel Tanis morì circa un mese dopo per le ferite
d’arma da fuoco riportate, mentre Willie Marins sopravvisse, ma perse un
occhio. Tre omicidi, tanti testimoni, nessun colpevole. Parte la prima telefonata
alla polizia e le prime testimonianze.
Si parla di una macchina bianca con
a bordo due uomini di colore. Qualcuno parla di Alfred Bello, un noto
criminale, visto correre per Lafayette street. La polizia dirama l’identikit
dell’auto ed è così che Rubin Carter ed un suo amico, John Artis, vengono
fermati. La macchina sembra coincidere con quella descritta.
«Alfred Bello had a partner and he
had a rap for the cops.
Him and Arthur Dexter Bradley were just out prowlin' around
He said, "I saw two men runnin' out, they looked like middleweights
They jumped into a white car with out-of-state plates."
And Miss Patty Valentine just nodded her head.
Cop said, "Wait a minute, boys, this one's not dead"
So they took him to the infirmary
And though this man could hardly see
They told him that he could identify the guilty men»
Him and Arthur Dexter Bradley were just out prowlin' around
He said, "I saw two men runnin' out, they looked like middleweights
They jumped into a white car with out-of-state plates."
And Miss Patty Valentine just nodded her head.
Cop said, "Wait a minute, boys, this one's not dead"
So they took him to the infirmary
And though this man could hardly see
They told him that he could identify the guilty men»
Al primo processo Bello e il suo
complice, Arthur Bradley, identificano Carter come uno degli uomini di colore
armati che avevano visto fuori dal bar la notte degli omicidi. Nonostante
Willie Marins non riconobbe Carter come
colpevole della sparatoria, la giuria, ( composta da 12 persone bianche) sulla
base della testimonianza di Bello, Bradley e l’assenso di Patrica Valentine(
altra testimone oculare), condannò Hurricane e il suo amico all’ergastolo.
Nel frattempo Bello e Bradley
ritrattarono la testimonianza data al
processo del ‘67, ma il giudice negò la mozione. Tuttavia, gli avvocati della
difesa, sulla base degli elementi emersi nella ritrattazione, riuscirono a
convincere la corte suprema del New Jersey a concedere un nuovo processo, ma fu
una farsa e Carter e Artis furono di nuovo condannati a vita.
«All of Rubin's cards were marked
in advance
The trial was a pig-circus, he never had a chance.
The judge made Rubin's witnesses drunkards from the slums
To the white folks who watched he was a revolutionary bum
And to the black folks he was just a crazy nigger.
No one doubted that he pulled the trigger.
And though they could not produce the gun,
The D.A. said he was the one who did the deed
And the all-white jury agreed»
The trial was a pig-circus, he never had a chance.
The judge made Rubin's witnesses drunkards from the slums
To the white folks who watched he was a revolutionary bum
And to the black folks he was just a crazy nigger.
No one doubted that he pulled the trigger.
And though they could not produce the gun,
The D.A. said he was the one who did the deed
And the all-white jury agreed»
Quando tutto ormai sembrava
perduto, un ragazzo di colore, Lesra Martin, insieme ad alcuni amici, decisero
di interessarsi al caso di Carter lavorando sodo con i suoi avvocati. Il loro
impegno fu ripagato nel ’85, quando la loro petizione fu accolta dalla corte
federale del New Jersey. Il giudice federale Haddon Lee Sarokin sentenziò,
finalmente, che Carter e Artis non avevano avuto processo equo, affermando che
l’accusa era basata su motivi razziali. Carter e Artis furono prosciolti da
ogni accusa a loro mossa nel ’66.
19 anni di carcere e una brillante
carriera stroncata. E ora che Hurricane è venuto a mancare rimane solo il
rimorso per quello che sarebbe potuto essere. Il suo nome è stato riabilitato,
ma quel tempo, quei 19 anni, nessuno sarà più in grado di restituirglieli.
«Now all the criminals in their
coats and their ties
Are free to drink martinis and watch the sun rise
While Rubin sits like Buddha in a ten-foot cell
An innocent man in a living hell.
That's the story of the Hurricane,
But it won't be over till they clear his name
And give him back the time he's done.
Put in a prison cell, but one time he could-a been
The champion of the world»
Are free to drink martinis and watch the sun rise
While Rubin sits like Buddha in a ten-foot cell
An innocent man in a living hell.
That's the story of the Hurricane,
But it won't be over till they clear his name
And give him back the time he's done.
Put in a prison cell, but one time he could-a been
The champion of the world»